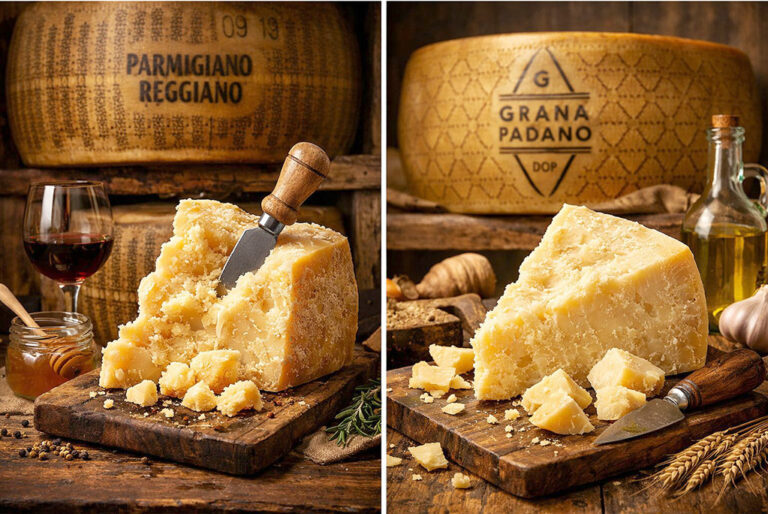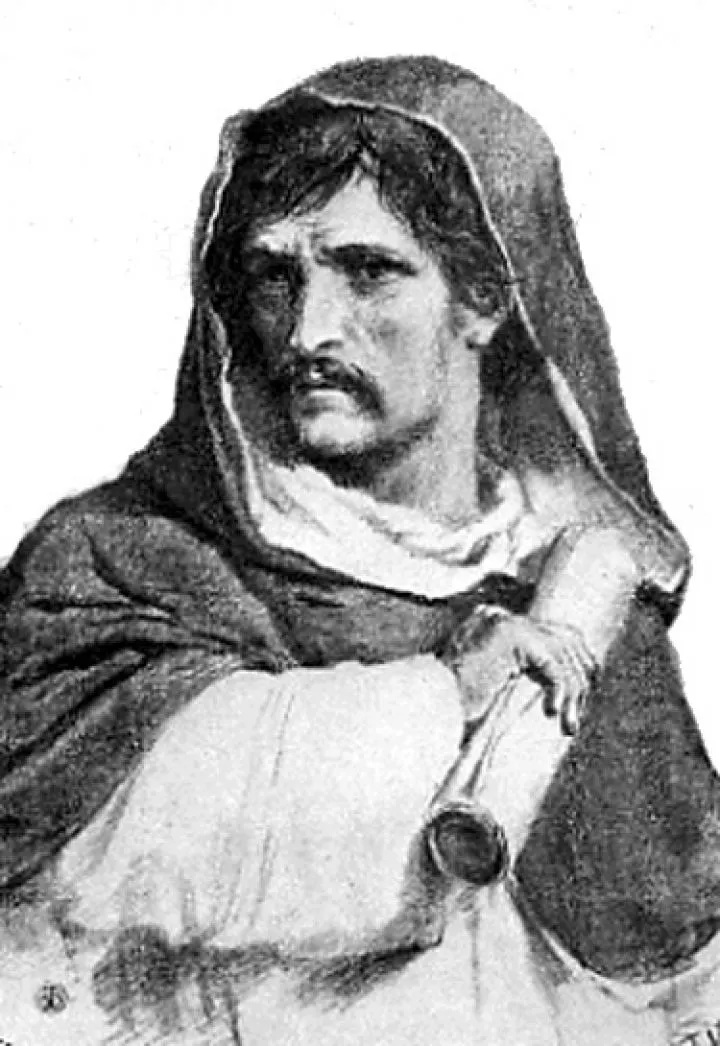di Elisa Sgubin | Rubrica Tendenze, Business, Cultura del Lavoro
A me è accaduto: rendermi conto di delegare sempre più compiti quotidiani agli algoritmi intelligenti. Scrivere gli auguri per le feste? Un messaggio standard, meglio lasciare la redazione a ChatGPT, Claude, e simili sistemi automatizzati.
Visionare un lungo e complesso rapporto? Perché preoccuparmene quando questi strumenti digitali possono riassumerlo e dare i punti chiave? Perfino i calcoli più semplici, che un tempo erano un allenamento mentale, ora sembrano tempo sprecato. Lasciare alle macchine pensanti le mansioni ripetitive è quasi un gesto di gentilezza verso una mente sovraccarica.
Molti di noi, alla ricerca di maggiore efficienza, hanno integrato l’intelligenza generativa nella propria routine quotidiana: ci fa risparmiare tempo, riduce lo sforzo e concede una tregua alle nostre menti, spesso affaticate dalla continua pressione di stimolazioni esterne.
Esistono dei rischi. Un numero crescente di ricerche evidenzia un effetto allarmante del demandare lavoro e compiti a questa competenza artificiale: si parla di erosione progressiva della nostra capacità di pensare.
Gli studi sono finora concordi: più affidiamo all’AI i compiti cognitivi, più tendiamo a delegare i nostri stessi processi di pensiero.
In termini psicologici, l’intelligenza artificiale sta diventando una stampella mentale. E proprio come una stampella fisica, se ci si appoggia troppo, i muscoli, e in questo caso, le facoltà mentali, si indeboliscono.
Tra gli effetti rilevati, è preoccupante come l’uso frequente degli assistenti digitali sia correlato negativamente alle competenze di pensiero critico, ovvero la capacità di analizzare, valutare e sintetizzare informazioni prima di prendere decisioni. Quando utilizziamo questi strumenti computazionali, spostiamo l’attenzione dall’elaborazione delle informazioni, alla semplice ricerca delle informazioni. Questa modifica, apparentemente minima, indebolisce la memoria, la capacità di risolvere problemi e l’autonomia decisionale.
Ancora più allarmante è il dato sui giovani tra i 17 e i 25 anni, che risultano particolarmente vulnerabili: cresciuti in un ambiente in cui l’AI è a portata di mano, ottengono punteggi più bassi nel pensiero critico rispetto ai coetanei che ne fanno un uso più moderato.
I predatori di questo declino cognitivo sono chiari. In ordine di impatto, occupa il primo posto la frequenza di utilizzo degli strumenti algoritmici: più elevata la frequenza, maggiore il rischio.
Influente è il livello di istruzione: un’istruzione più alta offre maggiore protezione dalla dipendenza.
Al terzo posto c’è l’assenza della lettura, di un pensiero profondo, il venir meno di discussioni critiche, la risoluzione di problemi complessi.
Alquanto insidiosa è la dipendenza da questi cervelli elettronici per le decisioni, chiedere consiglio all’AI su ogni aspetto quotidiano, ad esempio come interagire con i figli, come redigere un rapporto di lavoro, che polizza sanitaria scegliere.
Dare per scontato che l’intelligenza sintetica sia intrinsecamente positiva e un mezzo infallibile per risparmiare tempo è pericoloso: quanto più la consideriamo vantaggiosa, tanto più aumenta la possibilità di abusarne.
È allarmante il fatto che stiamo progressivamente disimparando a pensare, proprio nel momento in cui l’umanità avrebbe bisogno della massima lucidità per rimanere rilevante in un mondo del lavoro potenziato dagli algoritmi intelligenti.
Riconoscere la trappola di un uso eccessivo di questi sistemi porta a riflettere sul valore del proprio pensiero critico e sulla necessità di custodire il vantaggio, sempre più raro, di saper pensare in modo indipendente.
Una valida soluzione è porre un limite rigoroso all’uso dell’automazione cognitiva: utilizzarla solo per attività di supporto, come la correzione ortografica o la sintesi, e mai per pensare al posto nostro. Se un compito richiede analisi, giudizio o creatività, deve essere una nostra prerogativa.
Ma, ed è qui che la questione si complica, limitare l’uso dell’AI non basta. Se davvero vogliamo preservare e affinare le nostre capacità mentali, dobbiamo andare alla radice del problema: il sovraccarico dell’attenzione, che ci spinge a delegare tutto.
In un mondo iperconnesso, la nostra attenzione vive in uno stato di assedio permanente. Email, riunioni, notifiche dai social media, flussi infiniti di informazioni. Tutto frammenta il nostro focus in micro-unità scollegate. Non sorprende che ci si senta troppo stanchi per leggere un articolo complesso o scrivere un’email ben ponderata: i nostri cervelli sono sovrastimolati, affaticati, e cercano ovunque una scorciatoia.
Limitare l’uso degli assistenti algoritmici non basta: per non perdere la nostra capacità di attenzione e riflessione, serve uno sforzo consapevole e continuo. Dobbiamo riabituarci alla concentrazione, altrimenti l’automazione intelligente ci sembrerà sempre l’opzione più semplice e immediata, mentre il pensare continuerà ad apparire faticoso e ingombrante.
Può aiutare la pratica dell’ “Attentino Detox”, brevi periodi di disconnessione intenzionale per ricostruire la capacità di concentrazione profonda. Per una settimana si stabiliscono dei confini rigidi: niente social media, niente navigazione superflua, niente multitasking. Ci si concentra su un compito alla volta, si leggono libri reali, partecipando a conversazioni estese e riflessive.
Dopo una pausa rigenerativa, leggere non è più faticoso, analizzare le informazioni diventa stimolante, scrivere testi complessi torna a essere un piacere. La mente, liberata dalla distrazione costante, è sveglia e ritorna uno strumento potente, come dovrebbe essere.
Il vero ostacolo nel nostro mondo frenetico e iper-accelerato è trovare il tempo per rimanere attenti su una sola attività: quasi impossibile. Costruire una routine che protegga la salute cognitiva richiede non solo intenzione, ma anche costanza e impegno per fare fronte alla pressione sociale del “fare sempre di più, sempre più velocemente”. La vita moderna ci vede testimoni di un paradosso: per restare ‘intelligenti’, creativi e rilevanti, dobbiamo rallentare, proprio mentre tutto intorno a noi accelera.
Ogni volta che siamo tentati di lasciare che le macchine pensino al posto nostro, dovremmo fermarci a riflettere: lo stiamo facendo perché il compito è davvero meccanico, oppure perché ci manca la pazienza di pensare? Se è la seconda, allora è il momento di riprendere il controllo e affrontare il compito in prima persona, anche se può risultare scomodo, e spesso, anzi quasi sempre, più lento. Ma è il tipo giusto di lentezza, quella che rafforza la mente invece di logorarla.
Alla fine, il vero rischio dell’intelligenza sintetica non è che pensi meglio di noi, è che, poco a poco, ci porti a dimenticare come si pensa.
(Per approfondimento: https://www.psypost.org/ai-tools-may-weaken-critical-thinking-skills-by-encouraging-cognitive-offloading-study-suggests/ )